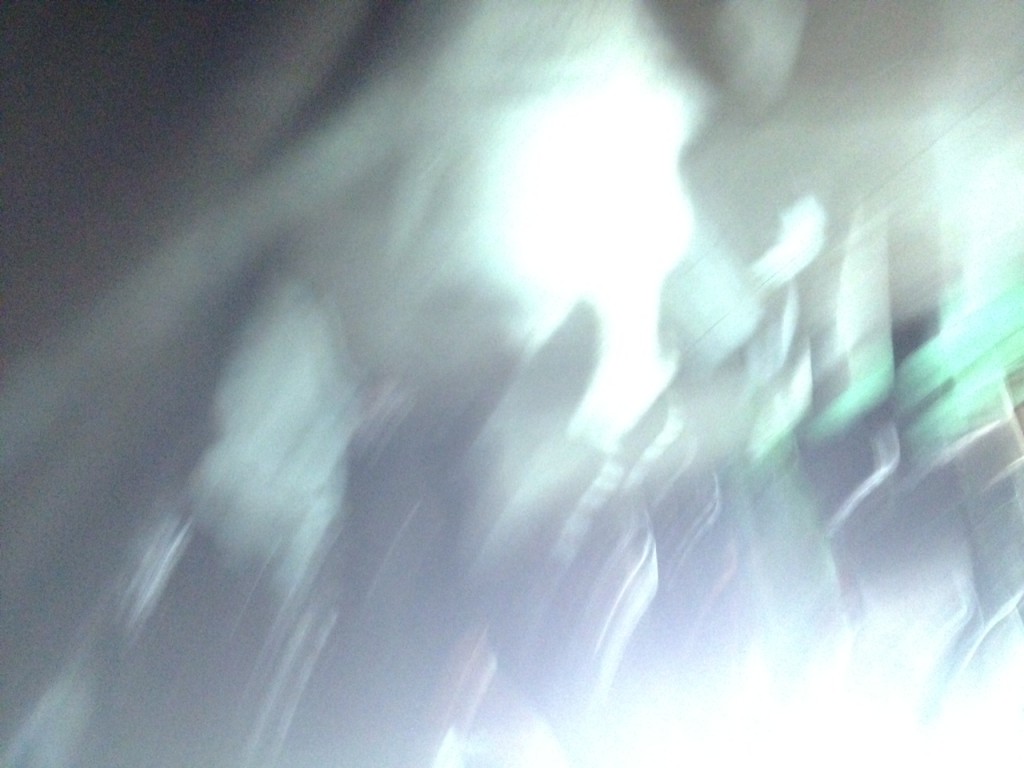Molto è stato scritto su Gli ambasciatori di Francesco I alla corte di Enrico VIII, dipinto firmato da Hans Holbain il Giovane nel 1533 e custodito oggi dalla National Gallery di Londra. Tra coloro che si sono spesi per darne una lettura puntuale, spicca Michel Butor, il quale, nei suoi Saggi sulla pittura, libro che consiglio vivamente, fornisce un’analisi impeccabile dell’opera.
Non solo Butor, personaggio assai sfaccettato, ma tutti gli storici dell’Arte concordano nel ritenere che i due ambasciatori siano la raffigurazione del potere temporale e del potere spirituale e che i ripiani dello scaffale presso cui posano, rappresentino, differenziandoli e unendoli al contempo, il Cielo e la Terra.
A noi, qui, non interessano le vicende dei due delegati, ma alcuni degli strumenti inseriti nel quadro sulla mensola superiore e sul pavimento, ovvero gli apparecchi astronomici utilizzati per individuare la posizione dei corpi celesti e il teschio realizzato con la tecnica dell’anamorfosi, tecnica che produce un’immagine fortemente distorta, la cui forma si rivela intelligibile solo se osservata da una particolare angolazione.
Gli apparecchi per guardare oltre, così come l’anamorfosi, spesso inclusa fra le suggestioni del precinema, erano fortemente presenti già nel Cinquecento e – attraverso i tre secoli successivi – ci conducono dritti alla fotocamera, salutata, fin dalla sua messa a punto, come una protesi in grado di dilatare le possibilità fisiologiche della vista umana, vestendo di visioni strabilianti il nostro povero occhio nudo.
Spazi siderali o microrganismi impercettibili, insomma l’invisibile declinato nelle sue forme più variegate: tutto poteva essere sondato, rivelato o millantato con la nuova tecnologia. Un’antica tensione diventava finalmente realtà.
Non è un caso che le contraddizioni scaturite fin dalle origini della fotografia da un’inedita e irresistibile frenesia dello sguardo, contagiassero anche uomini interessati più alla scienza che alla trascendenza.
A tale proposito, mi piace ricordare un piemontese, il poliedrico casalese Francesco Negri, il quale, nel 1885 circa, ottenne una preziosissima Fotomicrografia del Bacillo di Koch, ma, quindici anni prima, non rinunciò a rappresentarsi in un Doppio autoritratto spiritista: un divertissement che già metteva in discussione l’eccessiva credibilità conferita all’immagine fotografica.

Cielo e Terra, corpo e spirito, verità e menzogna. E una sola protesi. Protesi che produrrà un numero infinito di fotografie in grado di trasportarci dall’Ottocento fino ai giorni nostri. Citerò pochi esempi, i miei preferiti, forse chiarificatori, certo opinabili e non esaustivi: La Luna di Rutherfurd (1865), Giove e Saturno di Prosper e Paul Henri (1887), Raggi X del corpo umano di Zhender (1896), i tagli innaturali degli Equivalenti di Stieglitz (1923-1931) e dell’Onda verticale di Minor White (1947), i mari “immobili” dei Seascape di Sugimoto (a partire dal 1980), le Costellazioni di Fontcuberta (1993), in realtà moscerini spiaccicati sul parabrezza della sua auto, o, sempre dell’autore spagnolo, gli Emogrammi (1998), ovvero piccole gocce di sangue prelevate dagli spettatori che, drasticamente ingrandite, assumono forme poetiche e simboliche.

E a questo personalissimo elenco aggiungerei pure l’intero lavoro di John Hilliard che sulla fotografia e sulla fotocamera intesa come strumento protesico e illusorio, continua a riflettere e impartire buoni insegnamenti.
Tanta è la strada percorsa nella storia della visione, ma qual è la meta finale?
Mi piace pensare che la risposta si trovi proprio nel quadro di Holbein. Che, non dimentichiamolo, è un ritratto: gli oggetti che circondano gli ambasciatori compaiono per raccontare realisticamente e metaforicamente la loro storia. E lo stesso vale per noi. Per quanto dispositivi, protesi, suggestioni ci portino lontano, alle soglie dell’impensabile, il vero scopo delle nostre ricerche è e resterà sempre quello di dare un senso alla nostra esistenza.