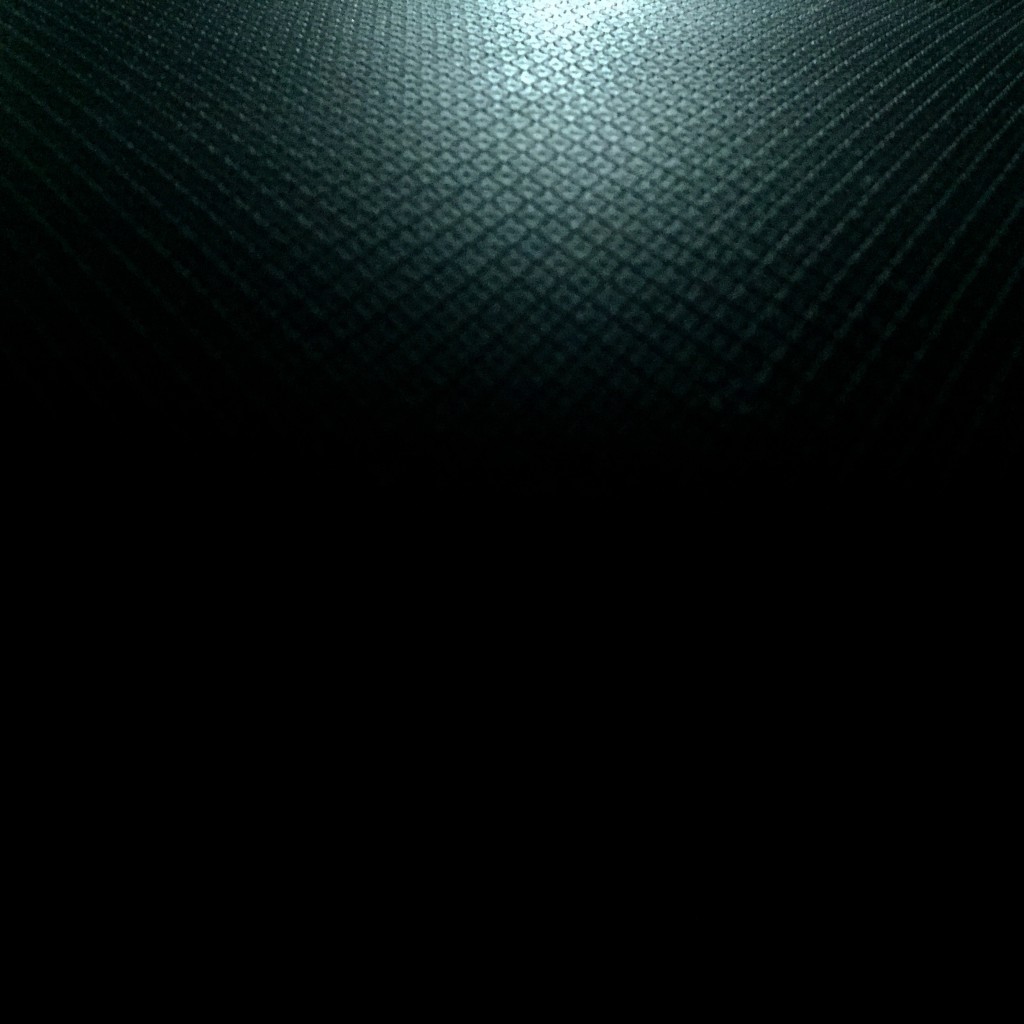
Riporto, nella loro forma pressoché originale, gli appunti scaturiti da un periodo di insonnia durato circa quindici giorni. Queste annotazioni avrebbero dovuto trasformarsi in un articolo, ma, dopo averle rilette più volte, considerato anche il carattere diaristico di un blog, ho preferito lasciarle così, scabre, disordinate e sospese come le notti che ho vissuto.
2 aprile, impossibile dormire, tisana + sigaretta.
Cerco di distrarmi.
Buio – notte – fotografia. Potrebbe essere un’idea…
3 aprile, ore 2,35, sigaretta
[Incipit] – Yves Bonnefoy, in Poesia e fotografia, prende in prestito un racconto pubblicato da Maupassant nel 1887 e intitolato La notte, per creare un parallelo tra l’esordio della fotografia e l’utilizzo dell’illuminazione artificiale in alcune zone di Parigi. Scrive Bonnefoy che, tale utilizzo, «influisce sicuramente in modo diretto sulla nostra relazione col mondo, sulla nostra inquietudine in sua presenza, poiché si contrappone a quella notte che l’immagine – l’immagine tradizionale – ha sempre avuto la funzione di tenere a distanza […]».
Città illuminate come palestre per generazioni di fotografi.
Le innovazioni tecnologiche del Novecento spalancarono le porte alla fotografia notturna, permettendo una sorta di inebriamento sperimentale collettivo. Esempio: le strabilianti autocromie che Léon Gimpel, nel 1925, dedicò alle insegne accese della ville lumière.

4 aprile, ore 3,14, sigaretta.
[Flaneur e topografi: da sviluppare] – L’impiego dell’elettricità in contesto urbano generò immagini ormai iconiche, imprescindibili dalla storia della fotografia. Basti pensare, per la felicità di tutti i flâneur, ai lampioni di Brassaï sotto cui si radunava un’umanità varia e dolente o, per la soddisfazione degli innumerevoli topografi, ai neon dei nuovi paesaggisti americani sotto cui regnava la desolazione perturbante delle periferie.


6 aprile, ore 5,27, sigaretta + tisana.
[Come nel romanzo di Fruttero & Lucentini: Quid noctis? A che punto è la notte?…]
I campioni degli appunti precedenti riscrivono e descrivono una notte che “sputa fuori”, ben lontana da quell’oscurità che – naturalmente e retoricamente – “inghiotte” tutto ciò che avvolge.
Allora mi chiedo: quando e in quale maniera la fotografia ha tentato o è riuscita a restituire l’«immagine tradizionale» della notte a cui fa riferimento Bonnefoy?
Questione intricata e perciò intrigante che poggia su una considerazione incontrovertibile: la fotografia è costituita di luce, mentre la notte, la notte naturale per intenderci, è permeata dal buio.
Ciò premesso, non posso comunque dimenticare che, per “temperamento”, la fotografia ha sempre tentato, più o meno maldestramente, di abbattere i propri limiti [tornare sull’argomento].
7 aprile, ore 2,15, gatto in braccio.
[La fotografia che aggira gli ostacoli – un cenno] – Sul finire dell’Ottocento, quando ancora apparecchiature e materiali sensibili non consentivano riprese soddisfacenti, ecco comparire i finti notturni creati in camera oscura da Gioacchino Altobelli, romano o da Carlo Naya, vercellese di nascita (Tronzano) e veneziano di adozione.

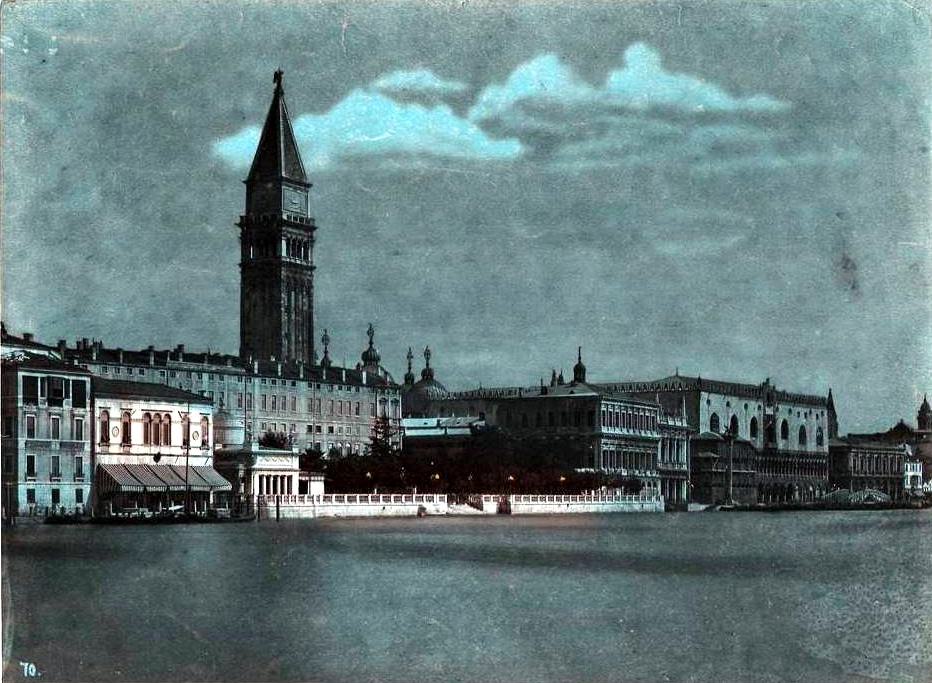
8 aprile, ore 2,54, guardo fuori dal bovindo, passano macchine…strascichi del sabato sera.
[Prosecuzione nota precedente] – Neppure i pittorialisti si sottrassero a questo genere di sperimentazione.
Di regola è Alfred Stieglitz a esser considerato il capofila dei “nottambuli”, ma, le sue immagini, pur se magistrali, sono in ogni caso collocabili entro l’indagine “luministico-urbana” che ho già menzionato.
Ritengo quindi più funzionale, in questo contesto, chiamare in causa l’arcinota fotografia The Pond Moonlight scattata da Steichen nel 1904. Debbo ammettere che, per quanto essa sia significativa, un po’ mi costa sacrificare in suo onore The Flatiron Evening (1906), altra immagine crepuscolare realizzata dello stesso autore con cui ho, da sempre, un forte e inspiegabile legame emotivo.



9 aprile, ore 4,08, sigaretta + tisana
[Notti astronomiche e pionieri – punto da sviluppare] – Fotografia astronomica, fotografia fortemente connessa all’osservazione notturna e decisamente in anticipo rispetto alle indagini di carattere artistico/autoriale. Già nel 1839, anno della presentazione del dagherrotipo all’Académie des sciences, il deputato François Arago valutò la possibilità di redigere una cartografia fotografica del nostro satellite.
Due esempi, di cui uno “nostrano”: nel 1857, Padre Angelo Secchi fotografò la luna e realizzò due stampe all’albumina oggi custodite nella Fototeca Panizzi di Reggio Emilia. Nel 1865, Lewis Rutherfurd eseguì una fotografia notturna e lunare grazie all’uso di un cannocchiale con apertura 11 ¼ pollici e fuoco 14 piedi (poi stampata con procedimento a carbone).


10 aprile, 3,12, gatto in braccio.
[Off camera/1] – Pionieri, astronomi, pittorialisti, flâneur o topografi fin qui evocati sono legati fra loro da un fil rouge, ovvero quello di aver praticato la fotografia servendosi di una fotocamera.
[Lasciare di proposito la fotografia off camera verso la fine dell’articolo. All’interno del mio ragionamento, ritengo che essa rivesta un ruolo di primaria importanza materiale e concettuale].
Sganciarsi da una strumentazione che poggia il suo funzionamento sulle basi di una forma prospettico-simbolica (Panofsky docet), significa infatti recuperare un rapporto più naturale con ciò che accade in presenza e in assenza di luce e significa pure riappropriarsi di tutto quell’apparato sensoriale che va acutizzandosi nelle ore notturne.
Per illustrare meglio questo pensiero, è bene riportare una dichiarazione di Jiří Šigut, artista ceco che, nel 1996, realizzò una straordinaria serie off camera, recandosi dopo il tramonto nei boschi per collocare carte fotografiche di grande formato, carte lasciate incustodite sotto l’azione della luce e recuperate dopo diversi giorni: «La parte fondamentalmente importante dei miei lavori contemporanei – spiega Šigut – è il mio viaggio serale o notturno nei luoghi dove colloco le carte. Notturno perché le distribuisco nel buio affinché la loro esposizione inizi con l’arrivo dell’alba. È un’esperienza del tutto nuova. Di notte, ho la sensazione di percepire tutto ciò che mi circonda con più intensità».
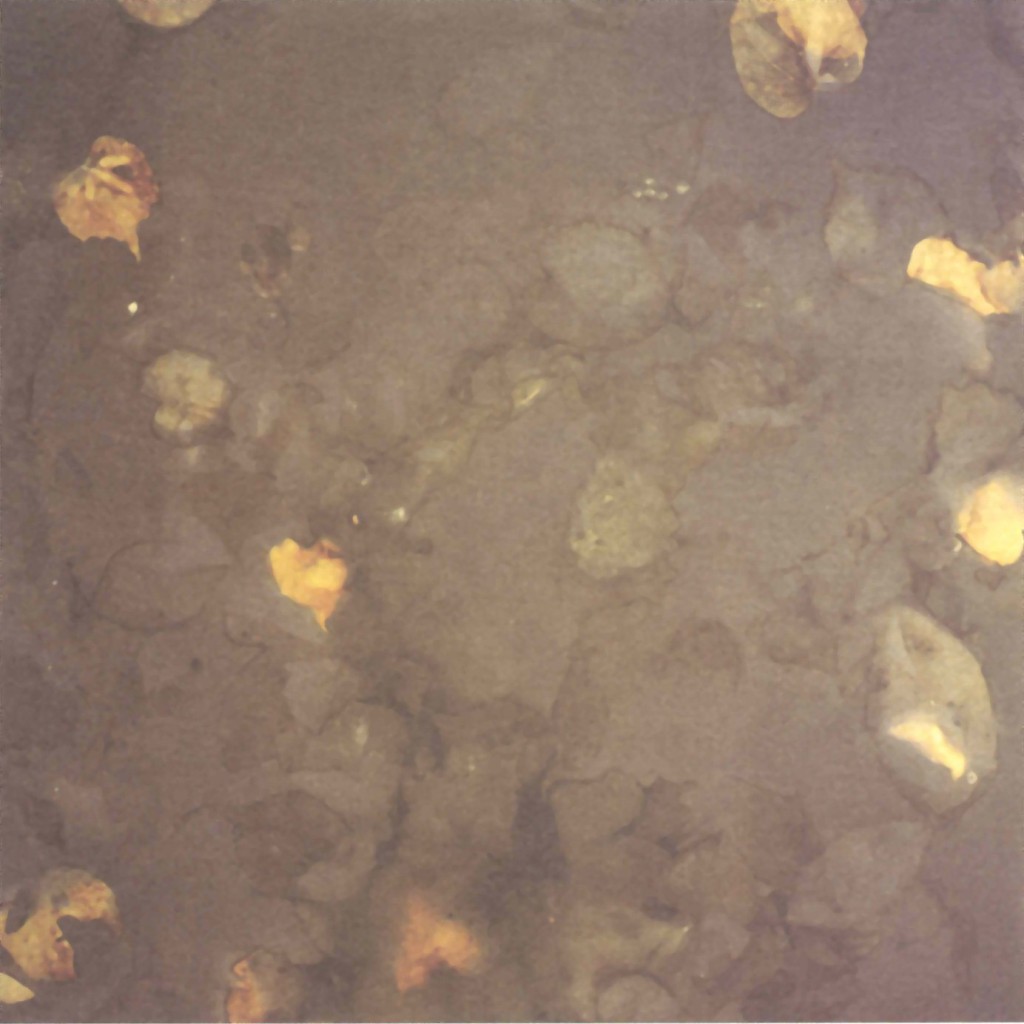
11 aprile, ore 1,55, sigaretta + tisana.
[Off camera/2] – Restando in ambito “off “, spingersi oltre per accennare al fatto che, grazie ai procedimenti ad annerimento diretto, possiamo assistere a un ribaltamento concettuale capace di imprimere sulla fotografia un ulteriore sigillo di ambiguità. Il nero assoluto è infatti ottenuto dalla bruciatura dell’emulsione sensibile, mentre il bianco, al contrario, è ricavato dal posizionamento di oggetti che negano alla luce la possibilità di aggredire i materiali. Nero = luce / Bianco = assenza di luce. Il giorno diventa notte e la notte si trasforma in giorno, provocando uno straniamento totale nel fruitore [sviluppare].

12 aprile, ore 4,44, tisana.
[Aspetto popolare e kitsch dell’immagine fotografica – solo un accenno] – Negli anni ottanta, quando essere in vacanza significava per forza esser più simpatici, furono immesse sul mercato delle cartoline completamente nere o oscurate che fornivano una versione by night della località turistica.
Infondo, questi oggetti senza alcuna pretesa se non quella di abbozzare uno scherzo, avevano involontariamente riportato la questione all’origine, declinandola in chiave contemporanea e anti-romantica.
La notte tornava a esser tenebra e a riconquistarsi la sua dose di incomunicabilità e mistero.
Saluti e baci.
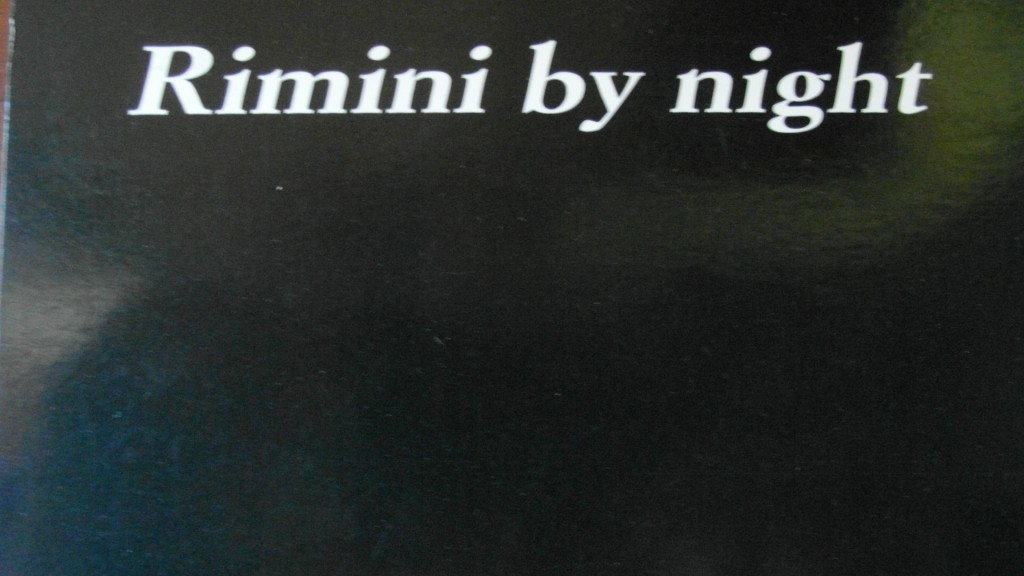
ps. Il 13 aprile sono partita per trascorrere qualche giorno al mare. E ho ricominciato a dormire.
![© Stefano Ghesini Salvadori, "Non tutta la meraviglia..." [particolare dell'installazione a cielo], 2017](http://www.lauramanione.it/wordpress_it_IT_4_2_2/wp-content/uploads/2017/03/mjhiondkpodnfllo.jpg)




![Domenico Torti, "L'assunzione della giovane arte Fotografica nel cielo delle arti belle", 1882 [particolare]](http://www.lauramanione.it/wordpress_it_IT_4_2_2/wp-content/uploads/2016/10/Nobel-oblige-1024x780.jpg)



