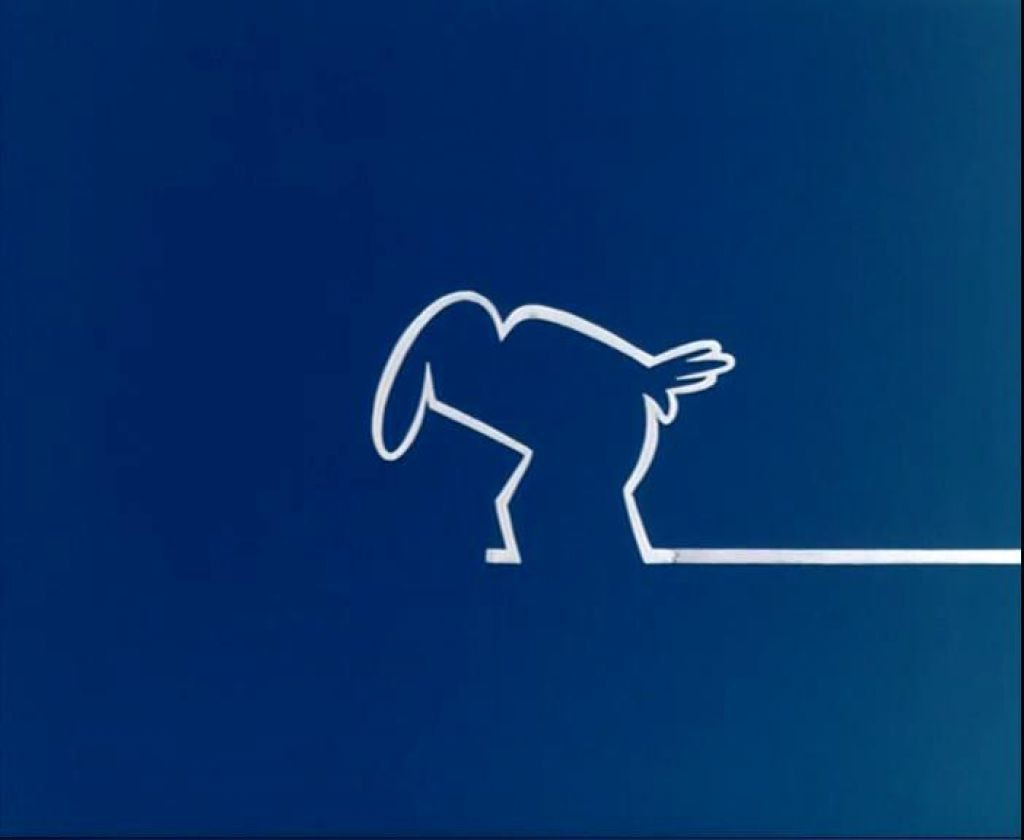
Premetto subito che questo articolo, inaspettato, scaturisce di getto da un post, estraneo alla fotografia, pubblicato recentemente su Facebook. Nondimeno, si sa, da cosa nasce cosa.
Dunque, la querelle, portata avanti sul social con molta intelligenza (vale a dire senza arroganza) riguardava il cantante, ex Cccp ed ex Csi ed ex ecc…, Lindo Ferretti, da qualche tempo palesemente distante dalla “linea” a cui aveva dichiarato fedeltà. Ora, essendo stata sempre una tiepidissima ascoltatrice di Ferretti, non mi cimenterò certo in una disanima che lascio volentieri ai suoi sostenitori o detrattori. O comunque a chi, al contrario di me, ha gli strumenti e l’interesse per poterla sostenere con competenza.
Da quella discussione, però, è nata una domanda che, in primis, pongo a me stessa e poi rivolgo a voi lettori: «quanto siamo disposti a perdonare i cambiamenti di rotta di chi amiamo e che per noi ha avuto un significato?». Ma, soprattutto, essendo questo uno spazio dedicato alla cultura fotografica: «quanto siamo disposti a perdonare le deviazioni di fotografi fortemente connotati dalle strade percorse nei loro primi anni?».
Gustave Flaubert, sosteneva che «L’artista deve trovare il modo di far credere ai posteri che non è mai esistito», affinché la sua opera, a qualsiasi forma espressiva essa appartenga, possa liberarsi dalla personalità che l’ha prodotta.
Eppure, per noi, certi autori diventano icone e feticci: abbiamo bisogno di biografie puntuali e sempre aggiornate, che arrivino persino dilatarne l’effettivo tempo vissuto sulla Terra. Tutto procede bene, fino a quando non intervengono “scoperte” in grado di scardinare il nostro rapporto adorante con il mito di turno.
Allora, per esempio, ecco nascere quesiti del tipo: «Se la morte del miliziano fosse un posato, come alcuni sostengono, Robert Capa sarebbe più o meno Robert Capa?» (a questo interrogativo, che trovo di una stupidità disarmante, vorrei rispondere: Capa resterebbe e resta sempre Capa, almeno per me).
Oppure: «Quel tale (sono tanti, non si possono far tutti i nomi) che è sempre stato fotografo militante, perché oggi espone nelle gallerie e vende all’asta? Perché non fotografa più solo per informare il popolo?».
Affrontiamo l’argomento da un’angolatura differente: anzitutto consideriamo quanti individui si dimenticano che la coscienza pulita ce l’ha solo chi non l’ha mai usata e quanti, per insano narcisismo, sbandierato snobismo e malcelata frustrazione, si votano a “sputtanare” (mi si perdoni il termine) gli altri piuttosto che a sottoporsi a una sana autocritica.
Poi chiediamo loro: «Chi si è collocato in una nicchia, ci deve stare tutta la vita per non svendersi? Sarà destinato, per non contaminarsi, a non campare mai di fotografia e a constatare che i fiori depositati dai pochi fedeli al basamento marmoreo, finiranno per essere gradualmente sostituiti dalle scritte di chi, con priorità ben differenti dal sentito omaggio, scriverà a caratteri cubitali “SAMANTHA TVTTB – IO E TE TRE METRI SOPRA IL CIELO?”».
Provo a formulare qualche risposta: sono convinta che l’arte o la fotografia (scindo i due termini che per me non andrebbero scissi unicamente per non urtare quei gran rompiscatole dei puristi) debbano essere diffuse e riconosciute, anche monetariamente, come professioni: non è riparandole dagli sguardi della massa e dai portafogli che le si protegge. Sarebbe il caso di indignarsi non per la diffusione o la retribuzione in sé, ma per l’ottusa carenza di politiche e spazi idonei all’arte e a chi la produce seriamente.
Ciò nonostante, il vero nocciolo della questione non sta lì, sta altrove.
Non è la pecunia che olet. È l’artista o il fotografo o il curatore (mi ci metto volentieri in mezzo) a puzzare quando smette di coincidere al 100% con la sua produzione. Poiché tutto si gioca sulla credibilità. Si può cambiare idea, religione, orientamento sessuale, pur continuando a riversare la piena consapevolezza di sé nella fotografia che si fa. Solo da un’evoluzione autentica non si passerà mai al furbescamente commerciale e da lì – fatalmente – al patetico.
Non stupiamoci dei mutamenti, se sono profondi e vitali, non facciamoci toccare dai giudizi che li accompagneranno: apparteniamo a quella condizione grottesca che è la vita umana e che ci rende fragili, volubili, ironici, deperibili e spesso soli.
Stupiamoci invece di esser talmente vacui da esser capaci di tradire noi stessi e talmente vanesi da pensare di darla a bere agli altri: è a quel punto che la linea si spezza.
Postilla
Ringrazio Francesco Faraci, bravo e credibile fotografo, per lo spunto involontariamente offerto con il suo post su Lindo Ferretti.
A corredo di questo articolo, suggerisco la visione di John Lydon’s Megabugs, diretto da Johnny Lydon Rotten nel 2014 e – sul blog di Efrem Raimondi – la lettura di: Parametro Pupo ( http://blog.efremraimondi.it/il-parametro-pupo/ ) e Forse ( http://blog.efremraimondi.it/fotografia-forse/ ).
